😵💫Apprendere, che fatica...
Questa è la cinquantesima newsletter del 2024. Ci "appendiamo" sulle trame sottili dell'apprendimento per costruire percorsi di conoscenza.
Non mi sarei mai aspettata di riuscire ad arrivare alla 50esima newsletter.
Ogni settimana, ogni lunedì, ho ritagliato un momento per scrivere queste mie riflessioni, nella speranza di poter essere di aiuto, di supporto o addirittura di conforto a qualcuno.
A qualcuno che, come me, si trova a vivere nella scuola, affogata in mille domande e, talvolta, annebbiata da milioni di impellenti scadenze burocratiche, ma con il desiderio inestinguibile di alzare la testa e vedere che mondo c’è là fuori.
A colloquio con “mio figlio ha diritto”
Qualche giorno fa, una mamma è venuta a colloquio, preoccupata per suo figlio dislessico. Temendo che si ripetessero esperienze passate di incomprensione, ha espresso il suo timore (o convinzione) che la scuola non facesse abbastanza. Mi aspettavo questa conversazione: prima o poi arriva sempre una mamma con questa angoscia.
Dopo anni di insegnamento mi chiedo ancora come sia possibile che il problema dell’andamento didattico degli studenti sia ridotto, da docenti, genitori e specialisti, alla questione dei voti, circoscrivendo l’insegnamento a strategie e tecniche didattiche, senza peraltro arrivare mai al nodo centrale: come funziona l’apprendimento?
L’apprendimento è inteso dai più (a seconda di come va l’interrogazione o la verifica) come voto: questo non è apprendimento, ma è la valutazione di una performance. L’apprendimento è una questione ben più complessa e variegata e dovrebbe avere come focus “come funziona l’apprendimento”, cioè come impariamo le cose.
Le teorie dell’apprendimento sono fiorite nel Novecento e molti docenti ne vantano la conoscenza, dichiarando di seguire una o l’altra, dalla tassonomia di Bloom alla zona di sviluppo prossimale di Vygotskij allo scaffolding di Bruner.
Per di più, adesso, siamo bersagliati di corsi sull’intelligenza artificiale e su come possiamo integrarla nella didattica. Oso ipotizzare che, in Italia, almeno un insegnante su tre quest’anno farà un corso su questa tematica. Insieme a tutti i rischi da cui tutti ci mettono in guardia, di fatto l’IA ha il grande privilegio di consentire la personalizzazione della didattica: questa potrebbe essere la svolta perché a tutti sia concesso di imparare al proprio ritmo e nella modalità più confacente.
È quello che si cerca di realizzare con i Piani personalizzati per gli studenti con Bisogni educativi speciali, progetto che nel dicembre 2012, cioè ben 12 anni fa, è entrato a pieno diritto nella normativa scolastica.
La personalizzazione non basta
Eppure più vado avanti nell’insegnamento e più sono convinta di una mia idea. La stessa che ho esposto alla mamma di cui sopra e che continuo ad esporre ai miei studenti. La faccio spiccia1 perché, qua ci sono addobbi da preparare e compiti da correggere. Non me ne vogliate.
Quando i nostri progenitori sono scesi dagli alberi e hanno iniziato a preferire la stazione eretta perché consentiva di avere due arti “liberi”, hanno iniziato a sviluppare la “manualità”, per la precisione, hanno preso a lavorare oggetti, scheggiando le pietre che poi sarebbero servite per attaccare bestie più grandi e feroci di loro. L’attività cerebrale è stata sollecitata tanto che le “conquiste” degli esseri umani si sono susseguite, dal fuoco, alla ruota al linguaggio. Anche la massa e il peso del cervello è aumentato.
L’apprendimento passa dal corpo: i piccoli umani, che ancora oggi ci inteneriscono, imparano a camminare non perché gli spieghiamo la teoria, ma perché sperimentano con il corpo.
Perché allora crediamo che, a sei anni, possano improvvisamente astrarre concetti complessi senza passare dalla corporeità? Questo è il primo inganno. La vera conoscenza richiede un impegno fisico: il cervello costruisce strade, o sinapsi, che si rafforzano solo con il tempo e l’esperienza ripetuta.
Non c’è niente di più falso: la capacità di astrazione che la conoscenza richiede deve necessariamente attraversare la corporeità.
La fatica dell’apprendere
Le strategie più sofisticate servono solo a un buon addestramento se non si rispetta il naturale percorso dell’apprendimento.
Anche la didattica esperienziale fallisce però. Perché per creare delle sinapsi solide, occorre più di un’esperienza folgorante. Immagino le reti neurali del nostro cervello come un intrico di strade ad alta frequentazione: le strade poco frequentate svaniscono, assorbite dalla giungla dell’ignoto, dello sconosciuto, del non più ricordo.
Il nodo cruciale
Si può ambire alla conoscenza nell’epoca in cui tutto è agevolato dall’intelligenza artificiale?
Sì, si può. Ma ad una condizione: rispettare il modo in cui abbiamo imparato ad apprendere.
“Mio figlio ha bisogno delle mappe”: certo Signora, alla fine del percorso, suo figlio ha bisogno delle mappe. Ma se viaggia nel vuoto le mappe non servono a collegare punti che non ritrova, perché sono senza nome.
È per questo che insisto con i miei studenti: prendi un libro, leggi un paragrafo e scrivi accanto, con le tue parole, quello che hai capito. Non è solo un esercizio didattico, ma un modo per legare corpo e mente, per costruire connessioni neurali stabili.
Per poter “estrarre” una conoscenza bisogna costruire strade nel nostro cervello. Perciò molto banalmente chiedo ai miei studenti, anche quest’anno, di lavorare così: leggere un paragrafo e scrivere accanto con la matita, a parole loro, quello che avevano capito. Perché la fatica di scrivere, di prendere in mano la matita o la penna e vergare il foglio, è il legame che istituiamo con la nostra corporeità.
Da qui in poi la comprensione può diventare astratta e possiamo imparare.
Ripeto spesso, che ogni giorno devono prendere il libro e ripassare, cioè ripercorrere la strada che hanno già tracciato. Purtroppo, non esistono strategie per eliminare questa fatica e se non decidono di affrontarla, la scuola sarà sempre un luogo ostile.
Anche quando spiego, insisto. Prendi un foglio, scrivi, magari ti segni una parola o fai un disegno della dea Atena, ma non è vero che non puoi prenderti un appunto, anche se sei dislessico. Mica devi stenografare la lezione. Ma perché le parole abbiano un peso e non siano volatili, vanno fatte passare nell’inchiostro, attraverso le ossa e i muscoli delle braccia e delle mani.
La costanza nel ripetere queste azioni ogni giorno costruisce strade e autostrade, attraverso cui il pensiero può correre.
Così si forma lo spirito critico,
così si allenano spiriti liberi che non si accontentano di essere intrattenuti per dire di avere imparato qualcosa (ma quanto sarà solida questa conoscenza?),
così si insegna ad apprendere qualsiasi cosa per uomini e donne indomiti, inarrestabili, coraggiosi esploratori del mondo.
Strumenti al servizio della mente
Poi con l’intelligenza artificiale possiamo esplorare mille cose. Può diventare un alleato straordinario: possiamo usarla per creare mappe, estrarre informazioni o sviluppare progetti complessi in pochi minuti. Ma c’è una condizione: deve essere al nostro servizio. La vera padronanza arriva solo se ci sostiene una conoscenza robusta, costruita giorno per giorno. Ad esempio, posso raccogliere informazioni sulle teorie dell’apprendimento con perplexity.ai, estrapolare informazioni con Notebook LM, e creare presentazioni o siti web con gamma.app. In 10 minuti.
Ma sono io che decido. Perché la mia conoscenza del mondo mi sostiene.
Buon caffè ☕
Simona
Questa teoria che sto grossolanamente esponendo è una rivisitazione della “embodied cognition” di Mark Johnson e Georg Lakoff.





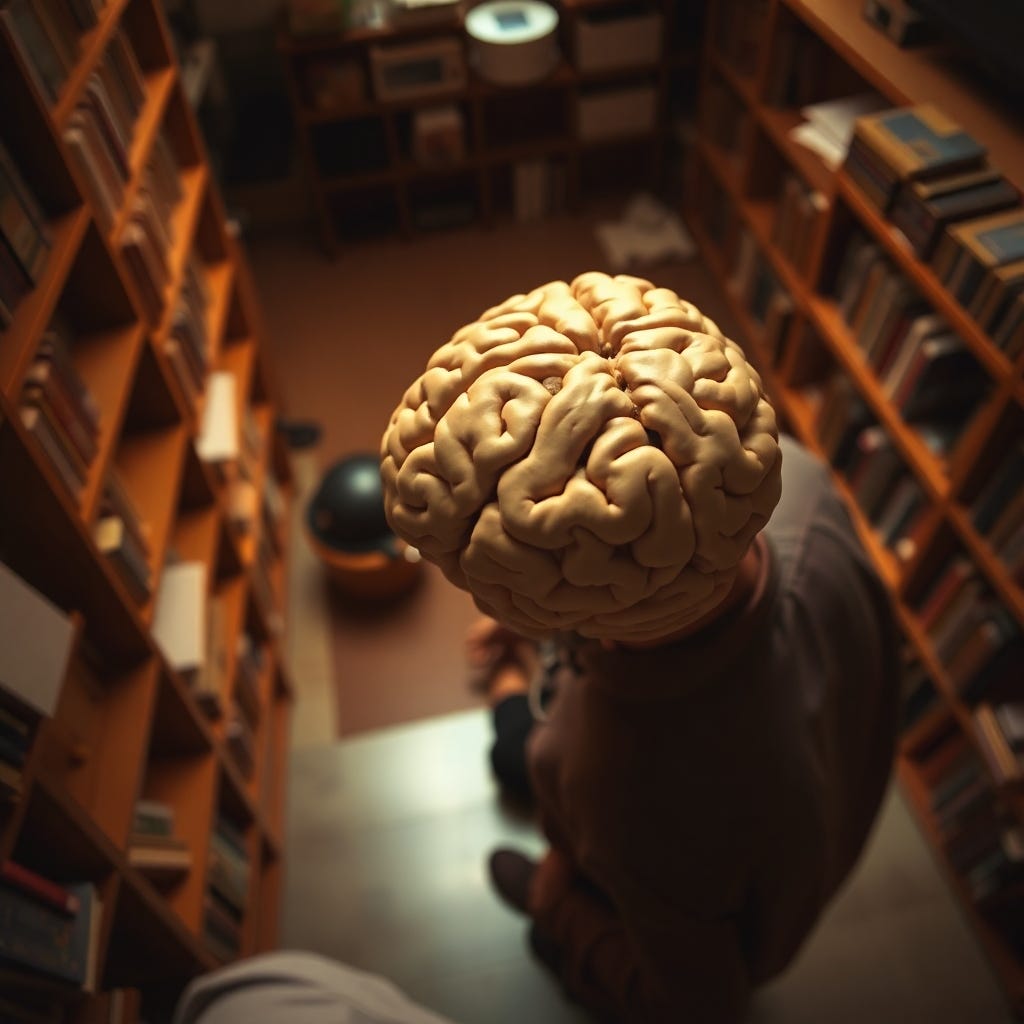

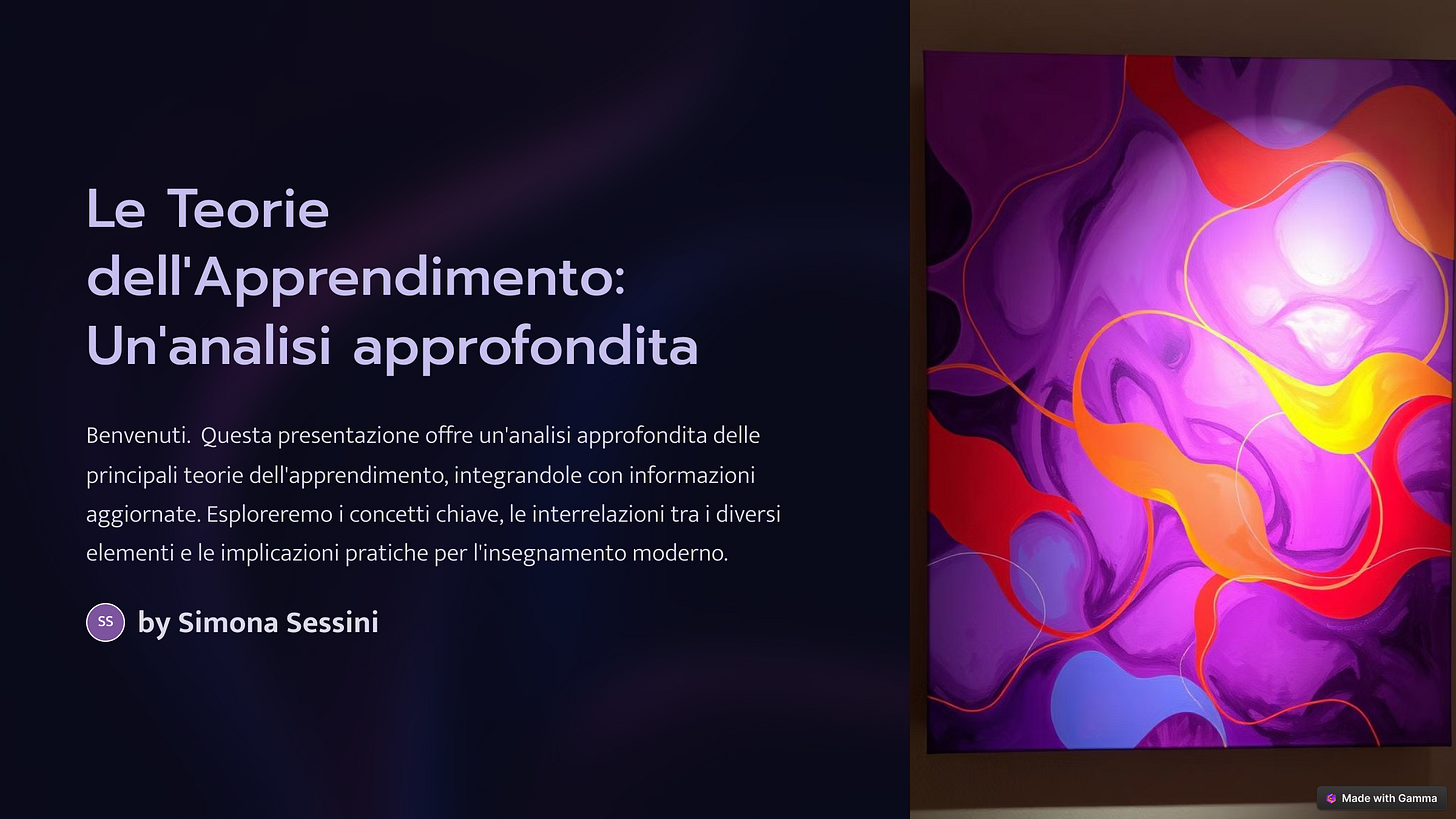
Sempre preziosissima